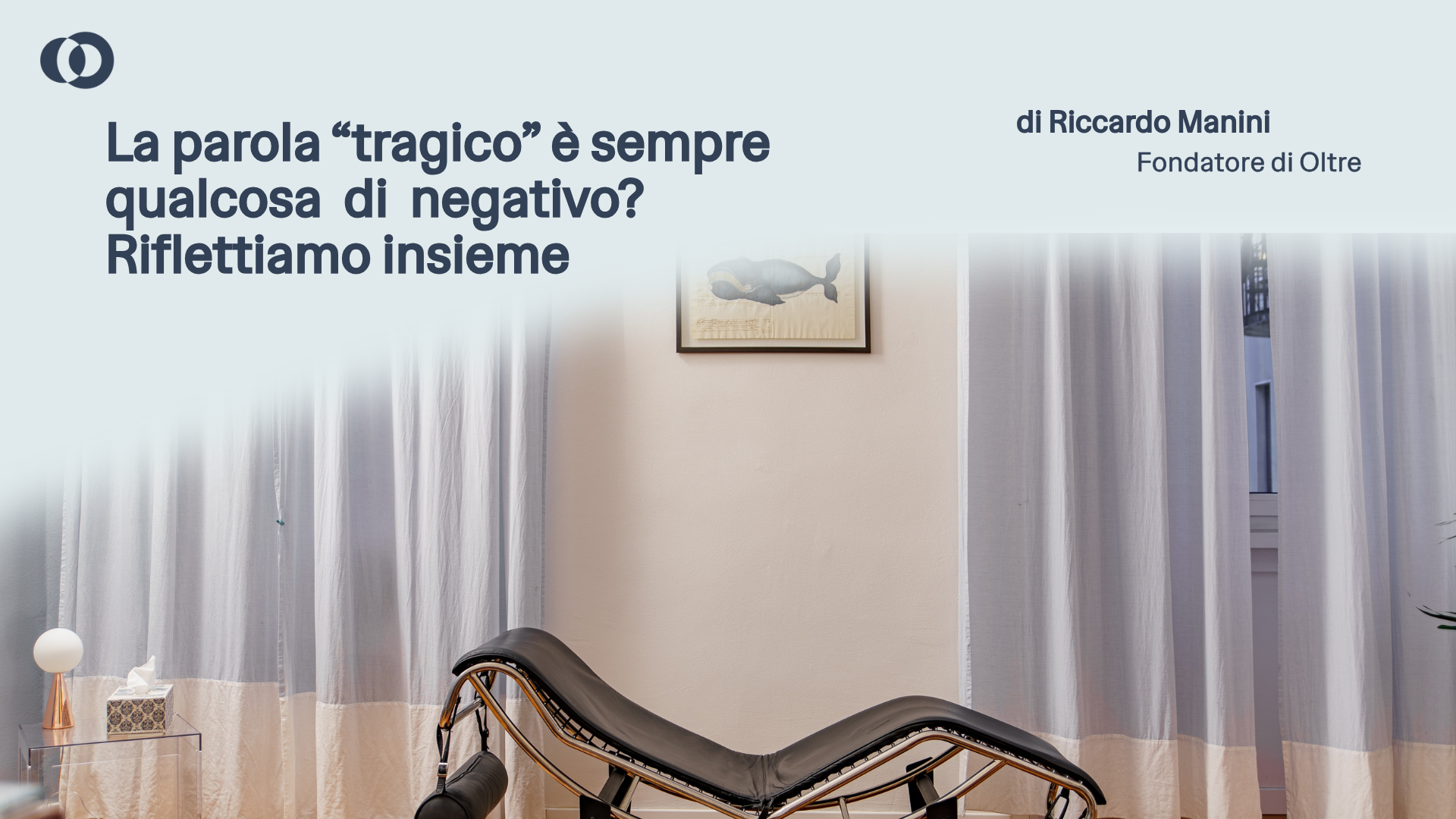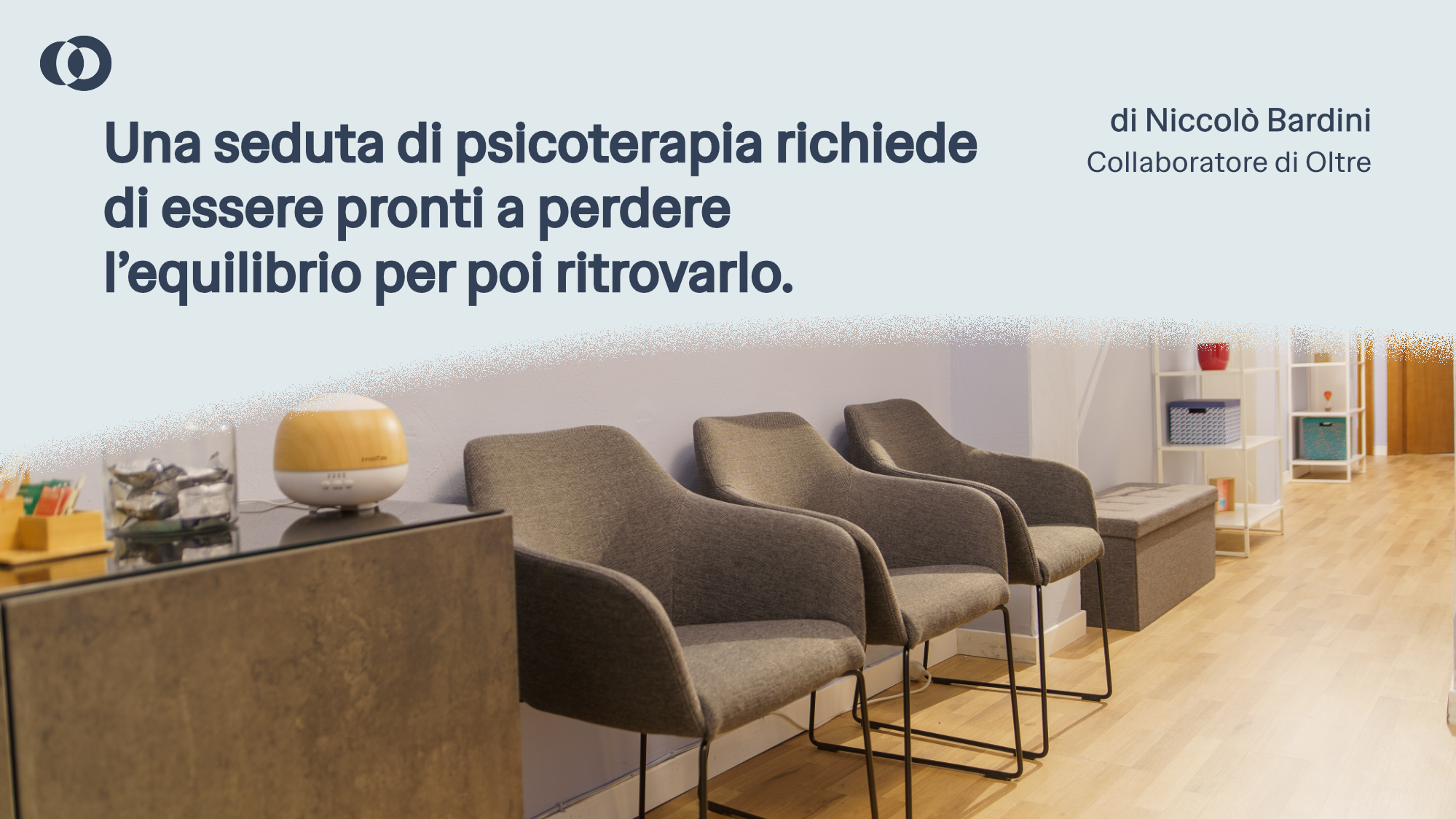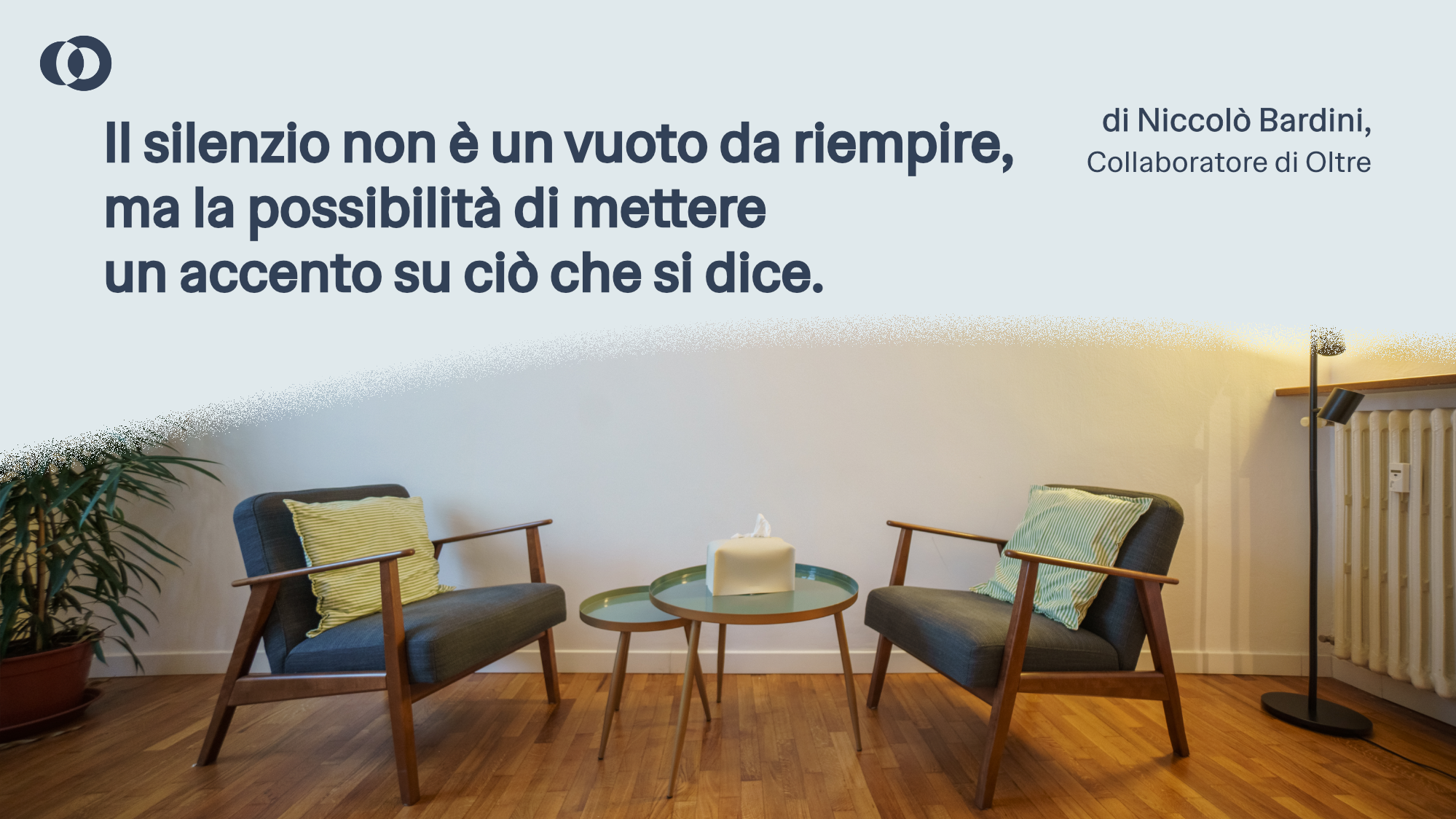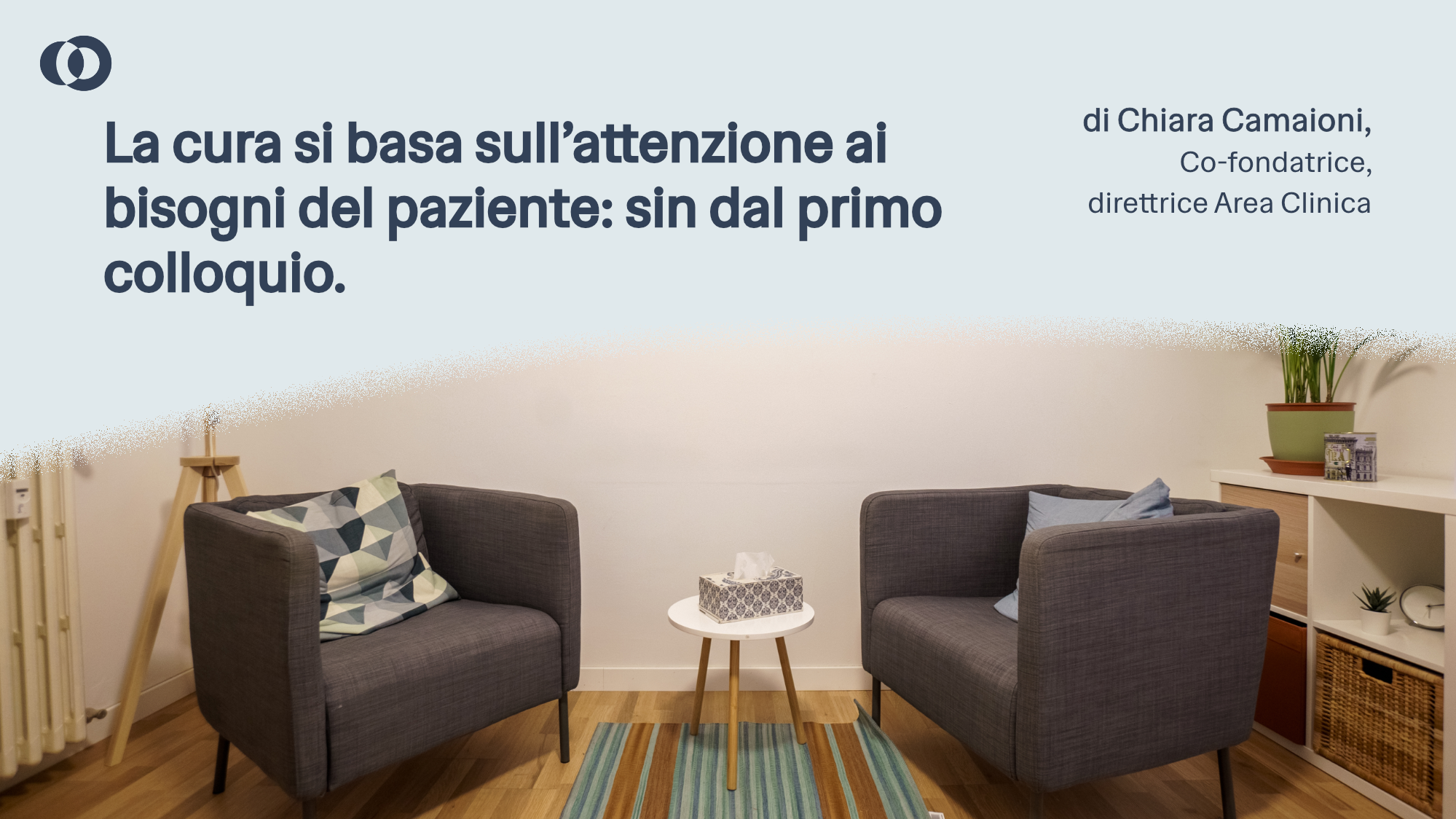Un percorso relazionale e intersoggettivo
Ogni coppia attraversa momenti di incontro e di distanza, di sintonia e di conflitto. Le relazioni affettive, per la loro stessa natura, sono dinamiche: cambiano con il tempo, con le sfide della vita quotidiana e con le trasformazioni interiori dei partner. Non sempre, però, la coppia riesce da sola a trovare un equilibrio tra bisogni, modi di stare insieme, desideri ed eventi di vita. In queste situazioni, la terapia di coppia rappresenta uno spazio privilegiato per esplorare le difficoltà e trasformarle in occasioni di crescita.
L’importanza della terapia di coppia
Le difficoltà di coppia spesso si esprimono attraverso conflitti ripetuti, silenzi carichi di significato o incomprensioni che sembrano insormontabili. Non si tratta semplicemente di “mancanza di comunicazione”: dietro queste dinamiche ci sono vissuti profondi, bisogni affettivi e timori legati alla storia personale di ciascun partner.
La terapia di coppia, sostenuta da evidenze scientifiche, si è dimostrata efficace nell’aiutare i partner a migliorare la comunicazione, ridurre i conflitti e recuperare un senso di vicinanza emotiva. Ma la sua efficacia non riguarda soltanto il benessere della coppia: spesso, il lavoro condiviso consente anche una maggiore comprensione di sé, favorendo un arricchimento personale e un miglioramento della qualità della vita.
La prospettiva della psicoanalisi relazionale e intersoggettiva
Uno degli approcci alla terapia di coppia che puoi trovare da Oltre si fonda sul modello della psicoanalisi relazionale e intersoggettiva. Questo approccio parte dal presupposto che i problemi della coppia non possano essere ridotti a colpe individuali o a errori comunicativi isolati. Ciò che accade tra i partner nasce dall’incontro tra due mondi soggettivi, ognuno con la propria storia, i propri bisogni e le proprie vulnerabilità. Viene quindi prima di tutto rivista l’idea di una verità oggettiva a cui riferirsi.
La relazione diventa quindi un campo intersoggettivo, dove le esperienze interiori dei due partner si intrecciano, si scontrano e si trasformano. Il compito dello psicoterapeuta è quello di aiutare entrambi a riconoscere questi movimenti, dando voce alle emozioni sottese e facilitando la possibilità di creare nuovi significati condivisi, partendo dal presupposto che ciò non è facile proprio perché la nostra soggettiva gioca sempre un ruolo cruciale nel creare significati. Il che vuol dire reagire spesso automaticamente a quello che il partner ci comunica.
Il contributo del costruttivismo ermeneutico
Un elemento centrale del nostro lavoro è rappresentato dal costruttivismo ermeneutico, che invita a superare l’idea di una verità oggettiva e unica riguardo ai problemi della coppia. In questo approccio, non esiste “la realtà dei fatti” che uno dei partner debba imporre all’altro; esistono piuttosto due verità soggettive, entrambe legittime, che spesso entrano in conflitto.
La terapia di coppia diventa allora il luogo in cui queste verità soggettive possono incontrarsi, confrontarsi e persino scontrarsi, ma in un contesto sicuro, sostenuto dallo psicoterapeuta. È proprio in questo spazio che diventa possibile attraversare i momenti di rottura, elaborare processi di riparazione e sperimentare forme di negoziazione nuove, capaci di restituire vitalità e autenticità alla relazione.
In altre parole, la verità non è un punto fermo da stabilire una volta per tutte, ma un orizzonte che si costruisce e si ricostruisce nel dialogo tra i partner, grazie al sostegno dello psicoterapeuta. Questo processo consente di trasformare il conflitto da ostacolo insormontabile a occasione di crescita reciproca.
Lo psicoterapeuta come facilitatore di incontro
All’interno di questa cornice teorica, lo psicoterapeuta non si pone come giudice né come arbitro che decide chi ha ragione. Piuttosto, svolge il ruolo di facilitatore di incontro, accompagnando la coppia nel riconoscere i propri bisogni, nel dare significato alle emozioni e nel trasformare modalità comunicative bloccate in possibilità di dialogo autentico.
Lo psicoterapeuta diventa una presenza terza che, proprio grazie alla sua posizione, può aiutare i partner a vedere ciò che da soli non riescono a cogliere, restituendo nuove prospettive e aprendo spazi di riflessione.
La possibilità di ritrovarsi
Il percorso di terapia di coppia non ha come unico obiettivo quello di “riparare” ciò che non funziona, ma di permettere ai partner di riscoprire modi più autentici e vitali di stare insieme. La psicoanalisi relazionale e intersoggettiva, integrata con la prospettiva del costruttivismo ermeneutico, offre uno spazio dove le difficoltà diventano occasione di trasformazione.
In questo processo, la coppia può ritrovare la capacità di guardarsi con occhi nuovi, di riconoscere i propri bisogni reciproci e di costruire significati condivisi che rafforzino il legame. È qui che il conflitto lascia spazio alla possibilità di riconoscersi nuovamente come partner, con fiducia, apertura e senso di progettualità comune.
Vuoi iniziare un percorso di terapia di coppia?
Presso il nostro centro di psicoterapia e psichiatria offriamo percorsi di terapia di coppia basati su diversi modelli teorici, per rispondere in maniera flessibile e personalizzata alle esigenze delle coppie:
- la psicoanalisi relazionale e intersoggettiva,
- l’approccio cognitivo-costruttivista,
- la psicoanalisi lacaniana.
Se desideri avere maggiori informazioni o fissare un primo incontro con uno psicoterapeuta del nostro centro, puoi scriverci a info@oltrepsicologia.it. Saremo felici di accogliere la tua richiesta e offrirti uno spazio di ascolto e di accompagnamento.