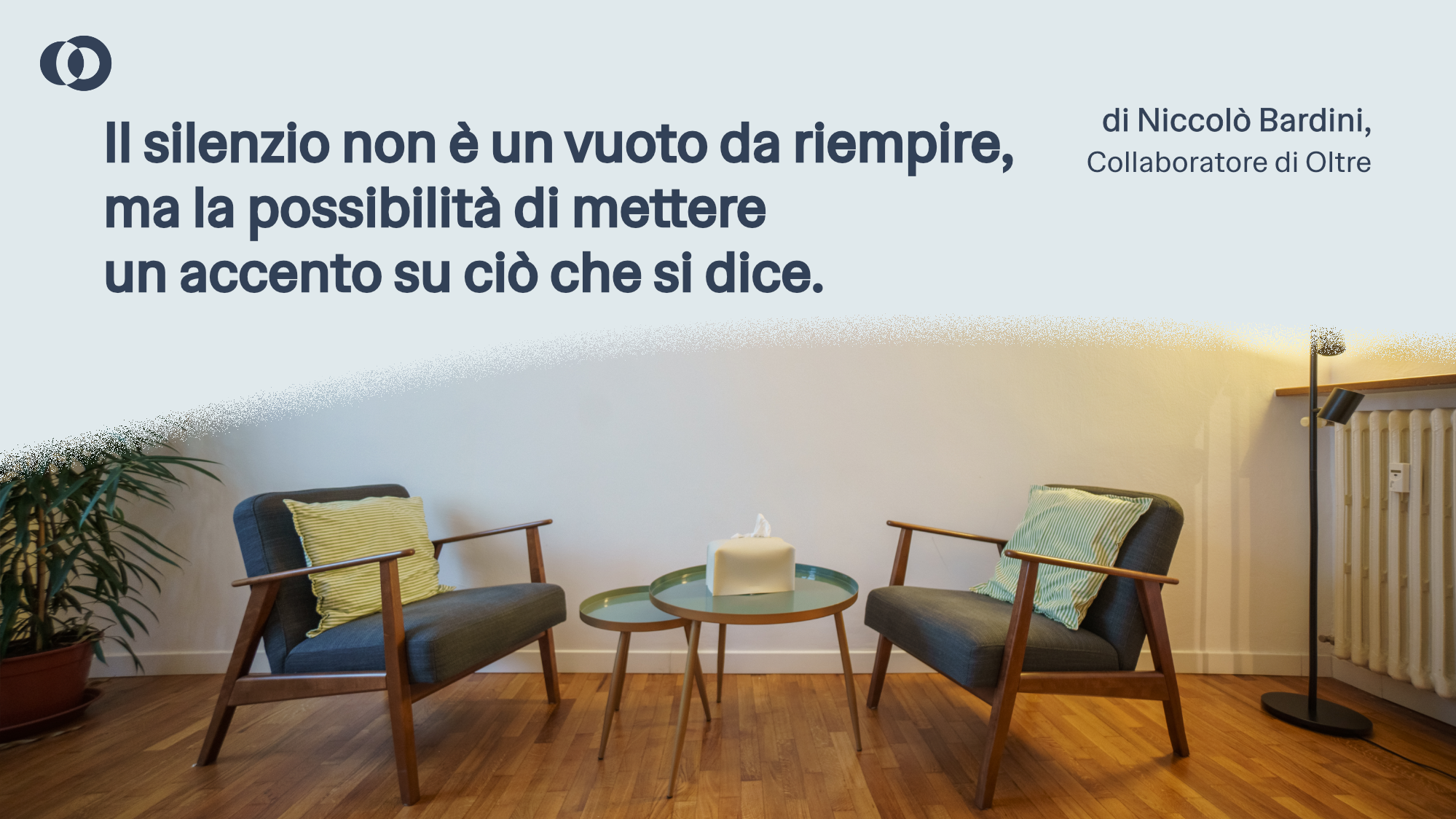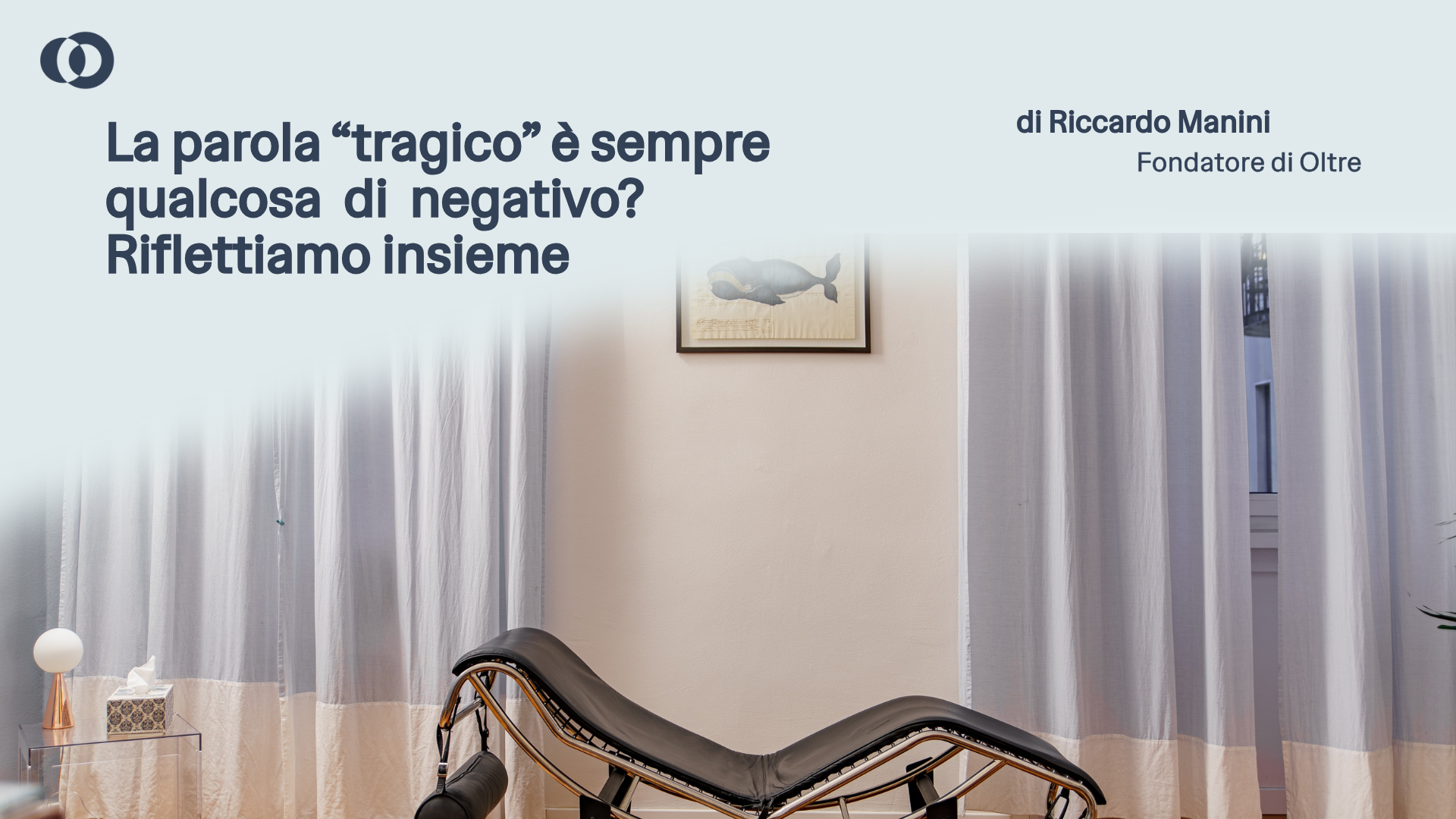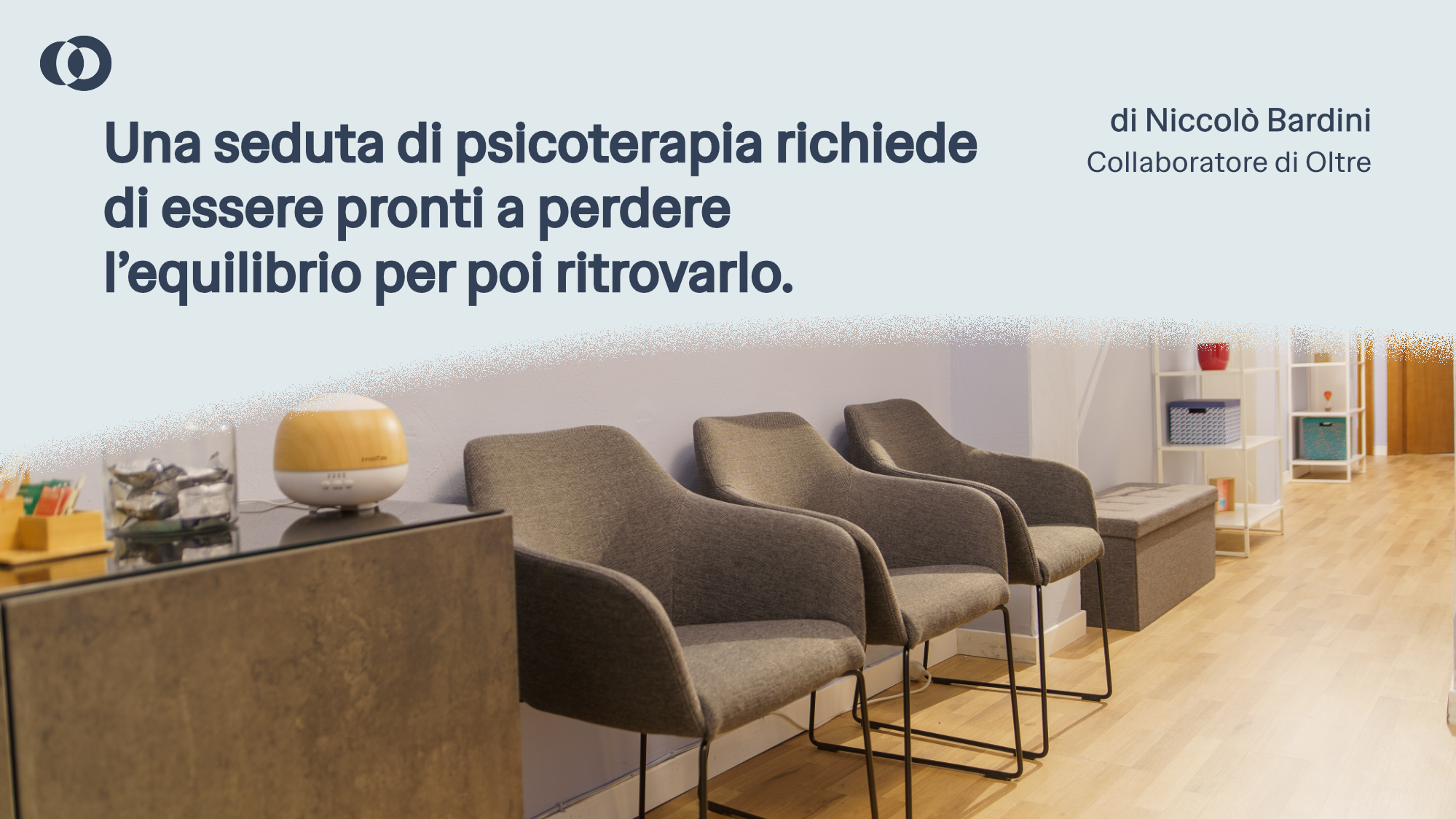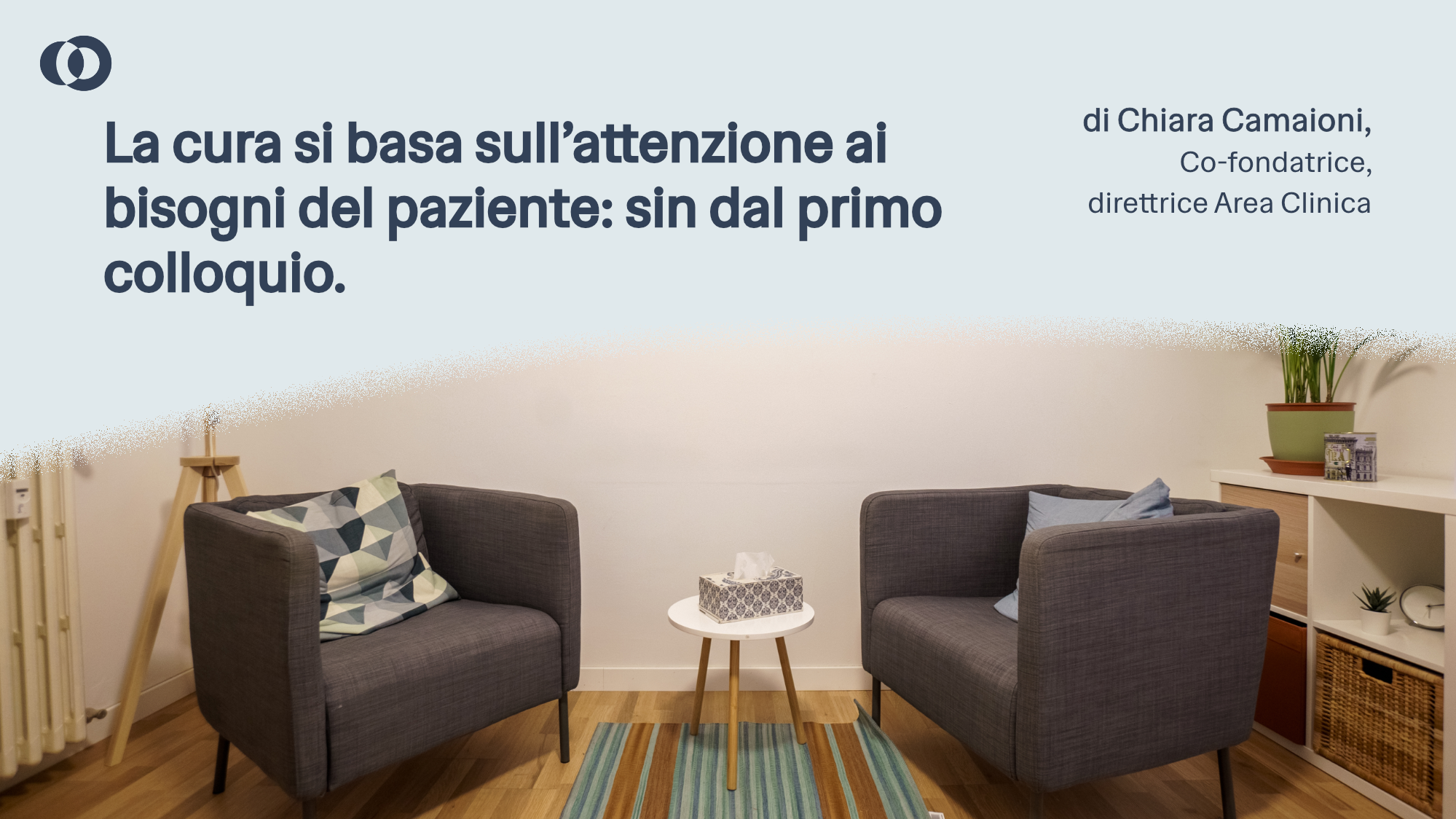Cominciare un percorso di psicoterapia significa affidarsi a una scommessa: che le proprie questioni, le proprie preoccupazioni, le proprie sofferenze, che spesso riguardano anche il corpo,
possano essere trattate con la parola. Cosa succede quando la parola è sostituita dal silenzio?
Il silenzio del terapeuta
L ’équipe di Oltre è composta di terapeuti che utilizzano diversi approcci, per permettere un intervento su misura per ogni paziente, sin dal momento dell’invio. Per questo, ogni terapeuta fa un suo uso della parola, così come fa un suo uso del silenzio. In linea generale, ci sono alcuni approcci che implicano una partecipazione più “attiva” del terapeuta, mentre altri implicano un minor intervento verbale: in entrambi i casi, al silenzio è affidato uno spazio particolare.
Può essere esperienza comune intendere il silenzio del terapeuta con vissuti svalutanti come una mancata comprensione, una sensazione di solitudine di fronte al proprio malessere, fino a una percezione di poca empatia. Se da un lato è possibile esplicitare queste sensazioni negative, interrogando il silenzio del terapeuta, dall’altro può essere utile pensare al silenzio come l’offerta di uno spazio libero. La psicoterapia si fonda sulla parola, ma non per forza la parola deve occupare tutto lo spazio della stanza, a discapito del detto comune “Se stai male parlane con qualcuno”. All’opposto, il silenzio può essere un momento di pausa in cui cogliere la possibilità di ragionare su quanto si è detto, o su quanto si dice sempre, su quelle cose di cui ci si lamenta, su quei discorsi che nessuno sembra comprendere appieno. In modo ancora più fondamentale, il silenzio può essere visto come un momento di sospensione della propria necessità di avere risposte, spesso immediate. Il cambiamento, un valore fondamentale per Oltre, non può prescindere da un lavoro di cura che va in profondità, dandosi il tempo di cercare le giuste domande prima ancora delle giuste risposte.
Il silenzio del paziente
Gli stessi vissuti svalutanti nei confronti del silenzio si possono provare quando, in qualità di pazienti, ci troviamo di fronte a un blocco, a un “non saper cosa dire”. È esperienza comune aspettarsi dal terapeuta l’offerta di un argomento di cui parlare: spesso infatti cominciamo un percorso di terapia quando abbiamo provato a ragionare in ogni modo sul nostro malessere e cerchiamo qualcuno che ci indichi precisamente cosa fare per risolvere le nostre questioni.
Se in generale il terapeuta, specialmente se afferente a determinati orientamenti, può proporre degli argomenti che valuta importanti, è più comune che la terapia sia uno spazio in cui si accoglie la domanda del paziente in ogni sua forma, compresi i silenzi. Parimenti al silenzio del terapeuta, il silenzio del paziente è l’occasione di uno spazio in più per poter riflettere su ciò che si vorrebbe dire ma non si riesce a dire, su quali sono i blocchi del proprio discorso, su quale siano gli argomenti difficili da trattare. Ad esempio, il silenzio potrebbe essere il risultato dell’idea che la nostra questione è così difficile che nessuna parola potrebbe spiegarla; oppure, il silenzio potrebbe essere causato da un sentimento di vergogna nello svelare parti di sé che non ci piacciono; oppure, potrebbe essere indice della nostra aspettativa di poterci affidare alla comprensione di qualcuno che ci tolga dalla fatica di doverci interrogare su qualcosa che ci fa stare male.
Un accento tra il “non rispondere” e il “non so cosa dire”
Ognuno dei silenzi illustrati e ognuno degli esempi riportati sopra rende chiaro che oltre alla parola è fondamentale lasciare spazio ai momenti in cui la parola viene sospesa o non arriva.
In conclusione, un’immagine evocativa presa in prestito dal teatro: l’unico modo efficace per mettere l’accento su una parola all’interno di una frase è far seguire a quella parola un attimo di silenzio più lungo degli altri. Provateci.
Ecco che il silenzio diventa un accento, un elemento della comunicazione che spicca rispetto al fiume di parole che si dicono (o si vorrebbero dire) nella stanza della terapia. Il silenzio, sia quando è utilizzato dal terapeuta, sia quando è incontrato dal paziente, permette di mettere la propria attenzione su una determinata parola, una determinata frase o un determinato argomento, aprendo alla possibilità di interrogarsi su cose nuove: farsi nuove domande è certamente il modo migliore per arrivare alle risposte che si desiderano.
Se senti di essere in un momento di difficoltà o desideri capire e meglio mettere a fuoco alcuni aspetti di te, puoi prenotare il primo colloquio di filtro gratuito. Inviaci una mail a info@oltrepsicologia.it